È aperta dal 21 febbraio 2017 la mostra di Keith Haring a Palazzo Reale di Milano. Sono esposte 110 opere dell’artista di grandi e grandissime dimensioni, alcune delle quali dialogano, o sono costrette a dialogare, con opere del passato: una lupa capitolina, una riduzione della Colonna di Traiano, maschere primitive, tutto ciò che ha dato, lo deduciamo dai suoi scritti, ispirazione ad Haring, perfino un Picasso.
Il percorso può essere molto interessante se l’osservatore aguzza la capacità critica e analizza il confronto fra passato e presente, per lo meno il presente di Haring, senza la sottomissione che spesso incutono le opere contemporanee. Di frequente capita che certe volontà di comunicazione non raggiungano il destinatario e capita che tali volontà siano interpretate e applicate a posteriori o dall’autore, o dai critici.

Gianni Mercurio, curatore della mostra, ha sentito la necessità di mettere a confronto opere che hanno ispirato Haring. Purtroppo l’iniziativa suscita delle perplessità, quando meno delle domande: era necessario? C’è forse una volontà di rendere autorevole ciò che, almeno nel mercato artistico, non ha bisogno di essere accreditato? Esiste ancora una critica che considera i graffittari arte di serie B (ma il problema si potrebbe estendere a tutte le espressioni artistiche), o è una questione relativa a Keith Haring e alla sua tendenza alla mercificazione, iniziata con le provocazioni di Warhol (di cui Haring era amico)?

Che Haring si ponesse dei problemi, che trovavano espressioni nelle semplici forme non mediate delle sagome è evidente. Le sagome, però, a guardarle bene, non sono rassicuranti e se, per esempio, nelle vignette di Jacovitti troviamo una satira che va al di là dei salami e dei prosciutti, in Haring troviamo una tensione, non solo sessuale, un’insofferenza latrice di un costante messaggio di morte. Che poi ci sia una rinascita non è dato sapere, intanto siamo costretti a convivere con una spada di Damocle che pende sulle nostre teste e inesorabilmente le trancerà (o trincierà a seconda che ci si identifichi con una sagoma, o con un polletto). E se sentiamo la necessità di paragonare l’artista a pietre miliari dell’arte mondiale, perché, liberati dai pudori dei benpensanti, non paragonarlo a linguaggi seriali, non necessariamente meno pregnanti? Ecco apparire Topolino, che diventa iconico personaggio slegato da ogni narrazione, una sorta di scarafaggio abbellito in cui l’uomo sembra incarnarsi. Appaiono le interpretazioni personalissime degli inferi (non per forza danteschi e per fortuna non browneschi), mostri che infliggono ai peccatori dalla spiccatissima verve sessuale (è comprensibile vista la malattia -AIDS- contratta da Haring, che lo ha portato alla morte) torture terribili e orrorifiche. Non si può evitare di pensare a Bosch, come non è facile non pensare a Matisse e a Picasso nella creazione delle figure simbolo dell’artista americano. Ma alla fine ognuno vede quello che vuole vedere e soprattutto vede secondo la propria formazione e la propria sensibilità, quindi che senso ha parlare di influenze analizzate a posteriori e possibilmente posticce?
Forse per tutte queste riflessioni la mostra potrebbe dirsi riuscita. Sicuramente smuove qualcosa nell’osservatore. Chiaramente ognuno deve rivendicare la propria libertà e autorevolezza nel dichiarare il proprio gusto.


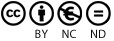


















Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
