In un isolato paesino irlandese vive Aileen con la sua famiglia. L’economia del luogo è tutta basata sulla pesca: gli uomini escono con le barche mentre le donne lavorano nella fabbrica locale che sfiletta e imballa il pescato. La vita è dura e spesso accadono tragici incidenti ma la comunità è unita, soprattutto quella delle donne, che si danno man forte a prescindere dall’età. Tutto cambia per Aileen quando dopo anni di silenzio torna a casa il figlio Brian, da un lungo e al quanto infruttuoso viaggio in Australia. L’idea del ragazzo è quella di guadagnarsi da vivere coltivando ostriche, un’attività di cui la sua famiglia detiene una preziosa licenza mai sfruttata. Ailleen fa di tutto per aiutare il figliol prodigo e nonostante lo scompiglio portato da Brian in famiglia, specie con il padre con cui aveva litigato prima di scappare all’estero, è disposta a chiudere più di un occhio per tenerlo ancora accanto a sé.

Nonostante gli uomini del villaggio vivano di pesca, chiarisce il film nel prologo, la tradizione impone che non imparino a nuotare, in una sorta di cieco attaccamento a un folclore senza senso, perpetuato in modo irragionevole. Imparare a nuotare significa sentirsi obbligati a salvare la vita di altri, meglio invece affidarsi all’andamento delle maree, anche se spesso il morto ci scappa. Le donne accettano di buon grado la perdita di un marito o di un figlio, e quando la giovane Erin dopo l’ennesimo funerale dice di voler insegnare a nuotare al suo bambino ancora in fasce, Aileen si oppone, ritenendo che la tradizione abbia un valore divino. Questo assurdo fanatismo sta alla base del racconto di Creature di Dio, che mostra come esistano anche nel mondo moderno (e in Occidente), sacche di un passato difficile da estirpare.

Creature di Dio delle registe Saela Davis e Anna Rose Holmer qui al loro debutto in coppia in un lungometraggio, descrive bene cosa un mondo ancorato al passato sia capace di infliggere a chi in esso non si riconosce più. È questo il percorso compiuto da Aileen, interpretata da una straordinaria Emily Watson, e la pellicola mostra cosa sia necessario fare per cambiare un sistema di valori radicato, e di come esista anche per una madre un punto di detonazione superato il quale il mondo non può che mutare. La protagonista è una donna di una certa età che vive in una comunità patriarcale che ha sempre accettato passivamente, cieca alla discriminazione fino a quando la natura del luogo in cui vive le appare violentemente chiarissima. Un ruolo decisivo in questo senso lo gioca anche la fotografia di Chayse Irvin, che crea un paesaggio cupo con una natura non certo idilliaca.
L’epilogo scelto dalla sceneggiatrice esordiente Shane Crowley risulta però troppo programmatico e rovina abbasta il discorso messo in piedi, ma si sa, toccare la maternità è spesso un argomento spinoso da gestire.


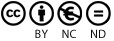















Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
