Il brillante incontro con il pubblico di Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, Freaks Out e La Città Proibita, al Trieste Science + Fiction Festival, dove è presidente della giuria. Una chiacchierata densa di spunti tra cinema e videogiochi.
Sei un appassionato di videogiochi?
Sì, sono stato un abile giocatore quando ero piccolo. Sono nato nel 1976 e la mia è stata un’infanzia in cui si giocava nei cabinati: praticamente vivevo nelle sale giochi. Ho fatto tutto il percorso delle console fino alla PlayStation 2, poi ho lasciato un po’ perdere perché mi sono concentrato sul cinema. Adesso mi diverto con i giochi sullo smartphone e ho ripreso a giocare con la Switch 2.
Su cosa ti sei formato, quali sono i giochi della tua infanzia e quanto hanno influenzato il tuo cinema? In Freaks Out c’è, ad esempio, una citazione di Pac-Man.
Ho amato molto i picchiaduro, ma anche giochi come Bubble Bobble o Super Mario. Non so dire bene come abbiano influenzato il mio lavoro. Così come per i fumetti — di cui sono un grande collezionista — spesso mi chiedono se ne sia stato influenzato, ma in concreto non lo so esattamente. Credo che i videogiochi, come i fumetti, abbiano avuto il merito di farmi vivere in mondi assurdi: per questo faccio film di intrattenimento e cerco, con il mio lavoro, di dare forma a universi con personaggi che facciano da veicolo narrativo per lo spettatore.
A livello tecnico però non ti so dare una risposta precisa. Per me, ad esempio, è molto interessante Ready Player One di Steven Spielberg, per il modo in cui gioca con la macchina da presa. Io stesso gioco con i movimenti e le inquadrature: voglio che lo spettatore si trovi in un mondo immersivo, come accade in un’esperienza videoludica. A me piace molto la sfida che è alla base dei videogiochi. Mollo quelli troppo facili.
Hai mai pensato di dirigere un videogioco?
A dire il vero me lo stanno chiedendo, e sono molto interessato. Diciamo che ci sto pensando seriamente. Al momento sto lavorando a un nuovo film, ma il budget richiesto è piuttosto alto, quindi vedremo se l’operazione andrà in porto.
La tua idea di lavorare sul genere potrebbe essere applicata anche ai videogiochi?
Senz’altro, perché anche non volendo accadrebbe così. Noi facciamo quello che siamo.

Parlando del tuo lavoro: secondo te quanto è citazionista, in senso postmoderno, e quanto invece rielabora in modo creativo le influenze del cinema passato?
Spero che il mio cinema non si limiti a essere solo citazionista. Ci sono alcuni film che mi ricordano i mobili dell’Ikea, fatti di pezzi prefabbricati da comporre in uno schema già precostituito. Per me invece i pezzi vanno reinventati, ricomposti per creare qualcosa di nuovo.
Mi piace molto il cinema di Hong Kong, ma ho cercato di fare qualcosa di personale con La città proibita. Conosco bene quel linguaggio, ma ho voluto creare dei miei movimenti di macchina personali, usare il mio linguaggio: altrimenti i film diventano un’operazione che ha poco senso fare.
È necessario capire oggi come muoversi per dare una chance al cinema di genere italiano. Un western come Testa o croce? è praticamente invisibile, come se il pubblico dicesse di non essere interessato al western italiano a prescindere dai meriti del film. Perché? Bisogna produrre nuove strategie di marketing, come ha fatto la A24, creando anche una rete di contatti tra i vari mondi dell’audiovisivo.
Nel cinema, così come nella letteratura, ci sono le opere considerate “alte”, d’autore, e quelle “basse”, più popolari; mentre nei videogiochi mi pare che queste differenze si notino molto meno.
È vero, nel cinema questa differenza esiste, ma non so quanto riguardi il pubblico medio. La linea è molto sottile, e penso che ci siano sguardi unici che raccontano storie in maniera personale. Per me il cinema è arte e intrattenimento. In Italia viene diviso in due macrofiloni: la commedia e il cinema d’autore, come se nel genere non ci fossero autori. Dune, ad esempio, è un film di intrattenimento, ma ha uno sguardo personalissimo, quello di un grande autore — cosa che non si può dire per tanti film italiani.

Secondo te oggi è necessario modificare il linguaggio del cinema per venire incontro a un pubblico più giovane? Tu riusciresti a cambiare il tuo modo di raccontare le storie in questa prospettiva?
Quando giro ho una scaletta di lavoro molto precisa: scelgo le inquadrature, i movimenti di macchina, la fotografia, la recitazione degli attori, eccetera. Faccio tutto questo con la massima onestà, non per andare incontro al volere del pubblico, ma per fare il cinema che piace a me. Quando la mia voce non sarà più ascoltata, mi farò da parte e parlerà qualcun altro.


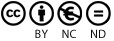












Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
