Ben Richards fatica a tirare avanti. Ha perso il lavoro e deve provvedere a una figlia malata, mentre la moglie è costretta ad accettare turni massacranti come cameriera. L’unica via d’uscita sembra quella di partecipare a uno dei reality show che imperversano in televisione, dove, rischiando la vita, si possono guadagnare parecchi soldi. Richards è sempre stato uno che non si piega, e il lavoro lo ha perso proprio perché non ha mai accettato le ingiustizie, cosa che, insieme alla sua prestanza fisica, lo ha portato all’attenzione di Dan Killian, il produttore del programma più redditizio, ma anche più pericoloso: The Running Man. Il gioco è semplice: deve scappare e sopravvivere per trenta giorni, prima che qualcuno lo denunci e venga giustiziato in diretta. Richards, per amore della famiglia, accetta, e la sua resistenza, nonostante le manipolazioni del network, inizia a diventare un punto di riferimento per buona parte della popolazione, che lo inneggia come simbolo di libertà.

Pubblicato nel 1982 sotto lo pseudonimo Richard Bachman, The Running Man, scritto da Stephen King, rappresenta una riflessione lucida e inquietante sulla deriva spettacolare dei media. La sua visione di un pubblico assuefatto alla violenza e pronto a trasformare la sofferenza in intrattenimento ha anticipato con sorprendente precisione dinamiche oggi centrali nella cultura pop: dai reality competitivi all’esposizione totale dei partecipanti, fino alla retorica dell’audience come giudice supremo. The Running Man è diventato un cult che ha influenzato opere come Hunger Games, Battle Royale e Black Mirror.
Nel 1987, l’idea prese una nuova forma e arrivò sul grande schermo in una versione che sembrava un parente lontano del romanzo. Al posto dell’uomo qualunque apparve Arnold Schwarzenegger, simbolo vivente degli eroi degli anni ’80, e il suo Ben Richards, da padre disperato, si trasformò in un soldato ribelle accusato ingiustamente. Anche il gioco televisivo cambiò completamente: non c’era più la fuga nel mondo reale, ma un’arena futuristica, illuminata da neon, in cui gladiatori moderni — gli Stalkers — davano la caccia ai concorrenti tra motoseghe, fiamme e armature stravaganti. Nonostante il cambio di registro, il film di Paul Michael Glaser, dietro una facciata spettacolare, conservava un nucleo del romanzo: la critica al potere dei media, la tv che manipola, il confine sottile tra intrattenimento e crudeltà.

Edgar Wright oggi riprende in mano il progetto e il suo The Running Man diventa una mediazione tra il pessimismo di King e l’adrenalina testosteronica dei film action degli anni ’80. Già la scelta del protagonista Glen Powell — biondo, belloccio e muscoloso, ma noto anche per commedie romantiche come Tutti tranne te — dà a Ben Richards una dimensione meno “atletica” di quella di Schwarzenegger, ma comunque lontana dal rappresentare l’uomo comune descritto nel romanzo. Stesso dicasi per il tono, che tiene perfettamente insieme azione e commedia, specie quando entra in scena Michael Cera in una sequenza davvero perfetta. D’altronde Wright sembra non essere secondo a nessuno quando combina questi due generi, riuscendo come pochi a graduare l’action e l’ironia, aiutato in questo caso da Powell, che ha la giusta faccia da schiaffi per questo gioco di rimbalzi.

The Running Man rischia di essere uno dei film più interessanti della stagione, soprattutto perché Wright ha una capacità di fare cinema spesso sorprendente: sequenze che, almeno sulla carta, avrebbero potuto risultare banali vengono trasformate in idee visive notevoli, come nella scena in cui Richards è chiuso nel bagagliaio di un’auto, risolta con un’ellisse narrativa che funziona perfettamente senza banalizzare l’ennesimo inseguimento. C’è poi un discorso a parte sul senso che The Running Man aveva avuto nella sua versione cartacea e che, in questa trasposizione moderna, a un primo sguardo potrebbe sembrare attenuato. Se è vero che molti temi non si distinguono da quelli di altri film recenti, è nella manipolazione delle immagini che risiede l’elemento più interessante del progetto. Se all’epoca di Glaser la sovrapposizione del volto di una vittima a quello di Schwarzenegger appariva futuristica, oggi la manipolazione di un filmato che mostra l’opposto di ciò che è realmente avvenuto è all’ordine del giorno. L’happy end finale diventa allora solo una possibile conclusione della storia: una falsificazione della realtà pensata per mettere in crisi lo spettatore, che può scegliere, al di là di ciò che gli viene mostrato (e della realtà che non può più esistere), il vero finale.






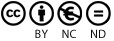
















Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
