Abang e Adik sono originari della Malaysia ma non hanno documenti che riconoscano la loro cittadinanza e per questo sono esclusi dalla società. Senza una famiglia che si prenda cura di loro, i ragazzi hanno stretto un profondissimo legame di fratellanza che li ha resi dipendenti l’uno dall’altro. Abang il più grande è sordo ma ha l’obiettivo di lavorare sodo per poter un giorno avere la vita tranquilla che tanto desidera, Adik invece preferisce le scorciatoie, fa soldi vendendo documenti falsi, si fa pagare per fare sesso e frequenta delinquenti locali. I due condividono un appartamento fatiscente nel quartiere di Pudu Pasar, sede dell’antico mercato di Kaula Lumpur, una metropoli gigantesca dove convivono culture e razze diverse. Per scappare ai continui raid della polizia e lavorare è necessario avere i documenti in regola, e l’unica che cerca di dare una mano ai due è l’assistente sociale Jie En che pare sulla buona strada per far ottenere almeno ad Adik la tanto preziosa carta d’identità.

Abang Adik vincitore quest’anno del gelso d’oro, il premio più importante del Far East Film Festival che si svolge ogni anno a Udine, è l’opera prima del regista melanesiano Jin Ong. Uno sguardo delicato ma allo stesso tempo potente il suo, su un fenomeno che coinvolge tutti i paesi del mondo, non solo quello dell’immigrazione clandestina ma, più in generale della povertà di chi vive ai margini della società. Nel film si parlano lingue diverse ma è la popolazione malese a detenere il potere politico e a controllare la polizia, mentre cinesi e cantonesi sono relegati a pura forza lavoro. In tali condizioni alcune fasce della società non hanno nessuna possibilità di cambiare la loro situazione e, non è un caso che Jin Ong scelga proprio di raccontare la storia di due giovani nel pieno degli anni. Abang in particolar modo sogna come tanti ragazzi della sua età di avere una famiglia, ma quando si innamora, la ragazza anch’essa immigrata, è costretta a rientrare nel suo paese.

Nonostante il fortissimo tasso drammatico del tema, Abang Adik riesce nell’ardua impresa di mantenere un equilibrio difficilissimo non scadendo mai nel patetico. Grazie a un racconto asciutto ma nel quale l’elemento visivo è importantissimo, Ong costruisce uno stile di regia elegante, con dialoghi ridotti all’osso, fino ad arrivare alla scena in cui Abang racconta al monaco buddista attraverso il linguaggio dei segni, muto e pure assordante per il suo significato, che cosa voglia dire essere privati della vita fin dalla nascita. Speriamo davvero che questa pellicola riesca a trovare uno spazio nella distribuzione dei cinema italiani.


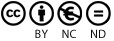


















Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
