Nel fitto calendario di incontri che ogni anno anima Lucca Comics & Games, l’appuntamento intitolato La Casa dei Rasoi, dedicato a Shintaro Kago e Jun Hayami, ha rappresentato uno dei momenti più attesi e affollati dell’edizione 2025. Moderato da Roberto Recchioni — autore, sceneggiatore e figura di riferimento del fumetto italiano contemporaneo — e con la presenza di Danilo Tucceri, curatore della collana Yami per In Your Face Comix, l’incontro ha offerto un raro confronto diretto tra due dei più rappresentativi esponenti del filone ero guro giapponese, termine che fonde eros e grottesco, e che indica una forma d’arte capace di oscillare tra attrazione e repulsione, bellezza e orrore.
Due maestri ai margini dell’industria manga
Shintaro Kago, classe 1969, è noto per un approccio radicale al medium del manga: la sua opera combina ironia surreale, deformazione corporea e riflessione metanarrativa. Le sue tavole, spesso costruite come esercizi di scomposizione anatomica e visiva, sono diventate simbolo di un’estetica che travalica i confini del fumetto tradizionale. Jun Hayami, considerato uno dei maestri del gekiga moderno, rappresenta un’altra declinazione dello stesso universo estetico. Il suo tratto, più realistico e diretto, indaga la violenza e la sessualità con una crudezza che non cede mai al compiacimento, ma sembra piuttosto cercare una verità nascosta dietro l’orrore. Entrambi, in modi diversi, si collocano ai margini dell’industria manga mainstream, preferendo un percorso autoriale indipendente, spesso controverso ma coerente.

Le influenze artistiche e culturali
A introdurre il dialogo è stato lo stesso Recchioni, che ha posto una domanda apparentemente semplice, ma in realtà cruciale per comprendere le loro poetiche. Jun Hayami ha scelto di non aggiungere molto, mentre Shintaro Kago ha dichiarato di non considerarsi erede del gekiga, sentendosi piuttosto influenzato da Katsuhiro Otomo e Masamune Shirow. Questa distinzione suggerisce la differenza tra realismo drammatico e sperimentazione concettuale tipica del suo stile.
L’estetica dell’ero guro e la sua funzione catartica
Un altro tema toccato da Recchioni ha riguardato il rapporto tra la cultura giapponese e la nascita dell’estetica ero guro. Jun Hayami ha negato l’etichetta, affermando di disegnare pace e amore, non orrore, spiegando che la sua rappresentazione della violenza ha un valore catartico e terapeutico. Kago, dal canto suo, ha spiegato che la sua visione nasce dal cinema e dalla sperimentazione visiva, più che da una pulsione morbosa.
Il nonsense dei Monty Python e l’umorismo visivo
Alla domanda sulle influenze internazionali, Kago ha citato i Monty Python, riconoscendo nel loro nonsense logico un’influenza determinante. L’influenza umoristica e surreale si riflette nella sua estetica visiva basata sulla deformazione e la satira corporea.

Affinità e differenze tra i due autori
Tucceri ha chiesto se Kago e Hayami percepiscano affinità tra le loro opere. Hayami ha risposto che le influenze comuni derivano soprattutto dal cinema, citando anche il neorealismo italiano.
Disegnare in diretta: il corpo come tema ricorrente
Durante l’incontro, entrambi hanno realizzato un disegno sul tema del mangiare, trasformando un soggetto semplice in una riflessione plastica su corpo e desiderio.
Dolore e arte: un dialogo tra culture
Recchioni ha proposto un confronto tra la tradizione italiana e quella giapponese nella rappresentazione della sofferenza. Kago ha parlato di un sentimento universale, mentre Hayami ha condiviso una riflessione personale sul pregiudizio culturale e la cordialità trovata in Italia.

Libertà creativa e indipendenza dall’industria
Si è poi affrontato il tema della libertà artistica e delle difficoltà economiche nel mercato manga. Hayami ha raccontato la scelta di abbandonare il fumetto commerciale, mentre Kago ha ribadito la propria decisione di restare fedele alla propria visione, anche a scapito del successo immediato.
I ritmi di lavoro e l’autonomia del mangaka
Recchioni ha posto una questione sul lavoro dei mangaka. Entrambi gli autori hanno dichiarato di preferire lavorare da soli per mantenere il controllo totale sul processo creativo, rifiutando la logica industriale che impone ritmi disumani.
Il caso Tsutomu Miyazaki e la crisi dell’horror
Tucceri ha introdotto il delicato tema del serial killer Tsutomu Miyazaki e della conseguente censura. Hayami ha ricordato come l’ondata di sospetto colpì anche lui. Kago ha raccontato che, da giovane autore, vide il mercato horror scomparire da un giorno all’altro. Un episodio che segnò profondamente la percezione della violenza nell’arte giapponese.

Censura e piattaforme digitali
Kago e Hayami hanno affrontato il tema della censura esplicita e implicita. Kago ha ricordato molte modifiche imposte alle sue tavole, mentre Hayami ha denunciato le restrizioni commerciali che oggi limitano la distribuzione online delle sue opere.
Il corpo come linguaggio visivo
Il dialogo si è spostato su una dimensione estetica. Per Hayami il corpo femminile è il centro della rappresentazione, mentre Kago lo considera un oggetto sperimentale da scomporre e ricomporre, privo di connotazione emotiva.
Sessualità, stigma e cultura giapponese
Rispondendo alle domande del pubblico, Hayami ha raccontato un episodio di discriminazione legato ai contenuti dei suoi manga, mentre Kago ha dichiarato di non aver mai subito episodi simili. Le loro esperienze mostrano la tensione tra arte erotica e morale nella società giapponese.

Il pubblico femminile dell’ero guro
Una discussione interessante ha riguardato la presenza crescente di lettrici tra i fan del genere. Hayami l’ha interpretata come forma di catarsi e immedesimazione nel dolore femminile, mentre Kago ha spiegato di aver imparato a considerare anche il punto di vista delle donne durante la sua carriera in riviste erotiche.
Critiche, consapevolezza e ricezione del pubblico
Verso la conclusione, Recchioni ha chiesto se abbiano mai condiviso critiche ricevute. Hayami ha ricordato un incontro con un docente che trovava nei suoi manga uno strumento di prevenzione, mentre Kago ha detto di ricevere spesso critiche da chi non comprende il suo lavoro.
Lucca come spazio di dialogo
L’incontro si è chiuso tra applausi, con le opere proiettate sullo schermo come testimonianza di due visioni opposte ma complementari. Entrambi hanno mostrato come, attraverso l’orrore e la bellezza, il fumetto possa ancora interrogare la mente e la sensibilità umana.








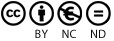

















Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
