Frankenstein segna il ritorno di Guillermo Del Toro a quella forma di cinema visionario e gotico che da sempre rappresenta la cifra più autentica della sua poetica. Si tratta di un progetto inseguito per oltre vent’anni, annunciato e accantonato più volte, rimasto a lungo ai margini della sua filmografia come un sogno irrealizzato, quasi quanto l’adattamento — mai concretizzato — di Alle montagne della follia di H.P. Lovecraft. Ora, grazie alla produzione Netflix, il sogno è divenuto realtà, sebbene con una distribuzione esclusivamente in streaming: una scelta che priva lo spettatore dell’esperienza visiva piena che un film di questa natura, tanto fisico quanto atmosferico, avrebbe meritato di vivere sul grande schermo.

Del Toro, come già ne Il labirinto del fauno o La forma dell’acqua, costruisce un’opera dove il fantastico non è mai mero ornamento, ma veicolo di riflessione morale e umana. In questa nuova trasposizione del romanzo di Mary Shelley, il regista messicano si confronta con una delle storie più riscritte e reinterpretate della modernità, scegliendo di non misurarsi tanto con la lettera del testo quanto con la sua eredità simbolica. Lontano dalla tentazione del semplice “aggiornamento” o della fedeltà filologica, Del Toro adotta l’approccio del traduttore infedele, consapevole che ogni adattamento cinematografico è, per sua natura, un atto di tradimento. Ciò che lo interessa non è riprodurre la trama, per quanto molto fedele, ma riattivare i temi fondativi del mito: la solitudine, la colpa, il desiderio di creare e la paura di essere creati.

Il punto di partenza di Del Toro è chiaro e radicale: fare di Frankenstein un film sulla paternità.
Non più, quindi, soltanto la storia di un uomo che sfida Dio per arrogarsi il potere di dare la vita, ma quella di un figlio cresciuto nell’ombra di un padre assente, incapace di amare e di insegnare l’amore. L’infanzia di Victor viene qui dilatata, analizzata nei suoi silenzi e nelle sue mancanze, descritta come il terreno fertile su cui germoglieranno l’ossessione e la solitudine del futuro scienziato. Il padre di Victor, nella visione di Del Toro, non è un mostro morale, ma un uomo distante, freddo, convinto che la disciplina e la sofferenza formino il carattere. Una figura che incarna quella genealogia di violenza affettiva che si tramanda di generazione in generazione, e che Victor finirà per riprodurre, inconsapevolmente, nel suo esperimento.

È in questa chiave che la creatura diventa, per Del Toro, un figlio alla ricerca di un padre. La relazione tra Victor e la sua creazione assume così un carattere profondamente umano, tragico e speculare: l’uno incapace di amare, l’altro disperato nel suo bisogno di essere amato. Non più, dunque, una semplice dialettica fra creatore e creatura, ma un dramma familiare che si riflette nel gesto stesso della creazione. In questo senso, Del Toro ribalta la prospettiva consueta del romanzo, offrendo una lettura che si avvicina più al mito di Abramo che al Prometeo moderno (che, non a caso era anche il sottotitolo originale dell’opera di Mary Shelley) inteso come parabola sulla responsabilità della generazione.

Interpretato da Oscar Isaac, Victor Frankenstein è ritratto come un uomo febbrile, dominato da un’ambizione che rasenta la follia, ma non privo di una fragilità nascosta. Del Toro ne accentua la dimensione ossessiva: l’amore per la conoscenza come rifugio da un vuoto emotivo, la ricerca della perfezione come tentativo di riconciliarsi con un padre interiore che non smette di giudicarlo. La sua incapacità di stabilire legami autentici trova eco nelle relazioni che intrattiene all’università e in quella, ambigua e dolorosa, con la fidanzata del fratello — relazione che il film descrive non come frutto di passione, ma come un malinteso fra anime ferite.

Quando Victor dà vita alla creatura, lo fa con la speranza inconscia di creare se stesso: un figlio che possa amarlo come lui non è mai stato amato. Ma ciò che genera è, inevitabilmente, un riflesso distorto del proprio trauma. Del Toro lavora qui su una sottile ambiguità morale: Victor non è un villain, ma un uomo incapace di compassione, e proprio questa sua cecità lo condanna. È il “peccato originale” dell’educazione ricevuta a riprodursi nel gesto creativo, rendendo Frankenstein non solo una storia di mostri, ma di eredità emotive.

A incarnare la creatura è Jacob Elordi, che offre una delle prove più intense della sua carriera. Il suo mostro non ha nulla della fisicità minacciosa delle versioni classiche: è un corpo giovane, quasi fragile, che porta addosso i segni di una nascita violenta ma anche di una struggente innocenza. Elordi riesce a restituire quella doppia tensione — verso la dolcezza e verso la furia — che fa della creatura un personaggio tragico e umano, sospeso tra la fame d’amore e l’istinto di distruzione. Il film segue la sua erranza come un percorso iniziatico: dall’attesa di riconoscimento presso il “padre” fino alla lenta presa di coscienza di sé, passando per gli incontri con figure che gli negano, una dopo l’altra, l’accoglienza e la pietà.

L’ultimo atto del film rappresenta il compimento di questo cammino. Victor e la creatura si ritrovano, si comprendono, si accettano: padre e figlio, finalmente riconciliati. È un finale sorprendentemente luminoso, per un regista che spesso ha preferito concludere le sue parabole con la malinconia dell’inevitabile. Qui, invece, Del Toro sceglie la speranza: Victor invita la creatura a “vivere”, non solo a esistere, e la pellicola si chiude con un’alba simbolica, con il sole che sorge su un nuovo giorno e illumina il volto del mostro.

Un’immagine che, nella sua semplicità, racchiude l’essenza dell’opera: la possibilità di interrompere la catena del dolore attraverso la consapevolezza e il perdono.

Chi conosce l’opera di Guillermo Del Toro sa quanto la dimensione visiva sia, per il regista, non un semplice strumento, ma un linguaggio autonomo. In Frankenstein questa cifra stilistica raggiunge forse una delle sue espressioni più compiute e, al tempo stesso, più problematiche. Del Toro riempie l’inquadratura di oggetti, tessuti, ombre, macchinari, elementi naturali e architettonici che convivono in un equilibrio fragile tra meraviglia e artificio. Il laboratorio di Victor, in particolare, sembra uscire direttamente dalle tavole di un illustratore vittoriano: un luogo di culto e di ossessione, più che di scienza, dove ogni ingranaggio sembra muoversi al ritmo di un cuore malato.

È lo stesso approccio che aveva contraddistinto Crimson Peak (2015): una messa in scena barocca, sontuosa, quasi teatrale, che tuttavia corre il rischio di soffocare l’emozione sotto il peso della sua stessa bellezza. In Frankenstein questo rischio si manifesta in più di un’occasione. Ci sono sequenze di grande potenza visiva — come la resurrezione della creatura, giocata su un contrasto cromatico di blu e ambra, o la fuga nel bosco sotto una nevicata lattiginosa — che però faticano a generare una partecipazione emotiva profonda. Lo spettatore resta affascinato, ma non sempre commosso.

Il film, in altre parole, a volte guarda se stesso più di quanto guardi i suoi personaggi. Eppure, quando l’estetica si mette davvero al servizio del racconto, Del Toro ritrova quella magia che lo aveva reso un autore inconfondibile.

Meno riuscita, invece, è la componente digitale. La CGI del film risulta altalenante e, in certi momenti, persino datata. Gli animali ricreati in digitale — cervi, pecore, e soprattutto i lupi — tradiscono una resa visiva poco convincente, con movimenti meccanici e texture artificiali che ricordano produzioni di inizio Duemila. È un difetto marginale nell’economia complessiva del film, ma non irrilevante: in un’opera che fa della cura estetica il proprio tratto distintivo, ogni elemento non perfettamente integrato stona e distrae. La sensazione è che la produzione, dopo aver accontentato Del Toro con scenografie opulente, abbia poi dovuto stringere la cinghia su qualcosa d’altro.

Al netto delle sue imperfezioni, Frankenstein rappresenta una delle prove più mature e coerenti di Guillermo Del Toro. Dopo alcune opere più incerte, il regista ritrova qui la sua voce più autentica: quella di un narratore che sa coniugare orrore e poesia, estetica e compassione. Il film non è privo di difetti — alcuni limiti tecnici, una certa compiacenza visiva, un ritmo diseguale — ma riesce dove molti adattamenti avevano fallito: dire qualcosa di nuovo su un mito che sembrava aver detto tutto. Del Toro non si accontenta di raccontare la storia di un mostro, ma esplora la genesi del dolore che lo genera. Il suo è un Frankenstein intimo, morale, profondamente umano, che trasforma la paura della morte in un invito alla vita.
L’ultima immagine, quella della creatura che guarda il sole, non è soltanto una chiusura poetica: è un atto di fede.
In un’epoca in cui il cinema d’autore fatica a trovare spazio, Del Toro ci ricorda che la luce può ancora nascere dal buio — basta, come dice il suo Victor, avere il coraggio di vivere davvero.









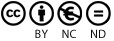






















Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
