A quarant’anni dalla sua realizzazione, L’Uovo dell’Angelo (Tenshi no Tamago, 1985) torna sul grande schermo a Lucca Comics & Games in una versione restaurata in 4K. Un evento che va ben oltre la semplice riproposizione di un titolo “di culto”: è stato lo stesso Yoshitaka Amano a salire sul palco per introdurre il film, ricordando come quest’opera, oggi guardata come il risultato congiunto di due autori “monumentali” come lui e Mamoru Oshii, sia in realtà, soprattutto, frutto di una squadra ampia e coesa. Amano ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di tutti coloro che contribuirono a realizzarla, soffermandosi con particolare commozione su alcuni collaboratori che non ci sono più: la proiezione, dunque, ha assunto anche il valore implicito di un omaggio.

Oggi come allora, il peso di questa opera nel panorama dell’animazione giapponese resta anomalo, elusivo, radicale. È un film che non chiede tanto di essere interpretato, quanto di essere attraversato. E se l’aspetto concettuale e simbolico continua a dividere, il comparto estetico appare invece meno esposto a contestazioni: L’Uovo dell’Angelo è, a tutti gli effetti, una tra le massime sintesi visive dell’immaginario di Yoshitaka Amano. Non solo nei caratteristici character design, nelle linee rarefatte eppure precise, ma soprattutto nella definizione dei fondali, che si presentano come vere e proprie cattedrali animate; architetture immaginate che però rimandano a un Medioevo europeo concretissimo, trasformato in un paesaggio mentale barocco, sospeso tra sacralità e decadenza. È un film che potrebbe essere messo in pausa in qualunque punto e che, a ogni fotogramma, offrirebbe un’immagine compiuta.

La narrativa, invece, non persegue chiarezza né linearità. È stato scritto che questo film sarebbe una sorta di “Stele di Rosetta” del modo di fare cinema di Oshii, formula coniata da Richard Suchenski su Senses of Cinema. Ma la metafora convince fino a un certo punto: la Stele di Rosetta era uno strumento per decifrare, L’Uovo dell’Angelo è semmai un enigma senza volontà di soluzione, un accumulo di simboli volutamente ermetici, un racconto che rifiuta struttura e conclusione in senso classico. L’opera si articola in una serie di quadri che hanno più a che vedere con l’onirico che con la grammatica filmica: lunghi momenti di sospensione assoluta, in cui il tempo sembra procedere per decantazione, seguiti da improvvisi lampi di dinamismo e violenza, in un’alternanza che non mira tanto a costruire una tensione narrativa, quanto un costante stato di allerta sensoriale. La colonna sonora di Yoshihiro Kanno, insistente e spesso opprimente, contribuisce a modellare questo spaesamento: lirica e inquieta, attraversa il film come un flusso di coscienza sonoro.

Non sorprende che Oshii, oggi, ammetta di non avere mai elaborato un’interpretazione definitiva del film. Non solo non offre una chiave, ma dichiara apertamente di non averla avuta nemmeno lui, invitando il pubblico a cercare un proprio percorso interpretativo. Questa ambiguità programmatica, che nel 1985 poteva apparire come una provocazione filosofica estrema, è forse uno dei motivi per cui L’Uovo dell’Angelo è diventato un oggetto di culto. Il suo valore non sta tanto in ciò che “dice”, quanto nella possibilità che offre di essere interrogato dallo spettatore, messo nella condizione di dover proiettare, sul vuoto delle immagini, il proprio immaginario.
Ciò che resta, a distanza di quarant’anni, è un’opera che anticipa molte delle tensioni estetiche e concettuali che Mamoru Oshii avrebbe portato avanti negli anni successivi: dal sogno indistinguibile dalla realtà (centrale in Lamù – Beautiful Dreamer, ma anche in Avalon) alla riflessione filosofica sulla coscienza e sull’identità (che si sarebbe compiuta in Ghost in the Shell). Ma L’Uovo dell’Angelo rimane forse la sua espressione più estrema e non mediata: non un film “sul” simbolo, bensì un film “di” simboli.

Per chi ama l’animazione giapponese, e in particolare l’idea di un’animazione come linguaggio dotato di possibilità autonome, questo ritorno rappresenta un’occasione rara. Pur nella sua opacità semantica e nella sua strutturale refrattarietà alla lettura univoca, resta un’esperienza che difficilmente lascia indifferenti. Non è un’opera che “si capisce”; è un’opera che si attraversa, che si assorbe per osmosi, e che forse – proprio perché non concede risposte – stimola un rapporto più attivo e più intimo con chi guarda.
In questo senso, il restauro in 4K non appare un semplice atto filologico, ma un gesto di restituzione: un modo per riportare questa esperienza percettiva allo splendore originario, per ricordarci come un film possa essere, oltre che narrazione, anche pura architettura di immagini. Un invito alla contemplazione. E, in fondo, un raro promemoria di ciò che ancora può essere il cinema d’animazione quando decide di non spiegare, ma di evocare.









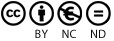
















Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
